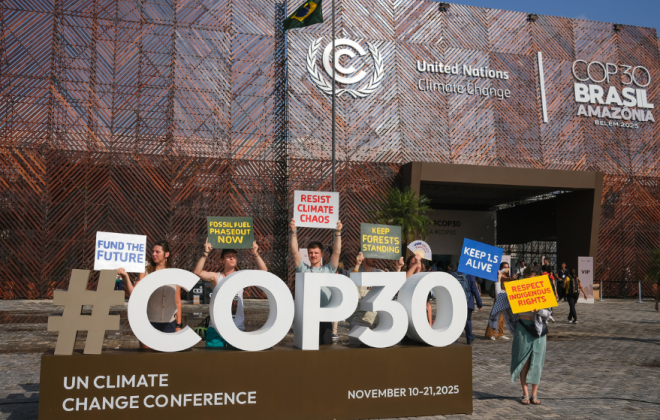Tagli degli aiuti e nuove sfide per la cooperazione
La drastica riduzione dei finanziamenti al settore della cooperazione e dello sviluppo rischia di mettere a repentaglio centinaia di programmi destinati alla tutela della salute, dell’istruzione e in generale dello sviluppo delle popolazioni più fragili.
di Rebecca Pezzotti
Il 2025 ha visto una significativa diminuzione dei finanziamenti internazionali destinati all’aiuto umanitario e allo sviluppo. Nell’ultimo anno infatti, sono state registrate grandi riduzioni sia nei contributi bilaterali, ovvero le risorse messe a disposizione dai singoli governi, (tra cui ci sono diversi paesi europei come Francia, Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito – sia nei finanziamenti multilaterali come i fondi erogati da diverse agenzie delle Nazione Unite, fondi globali, etc. Questa riduzione è legata a una combinazione di fattori: le crisi economiche e l’inflazione hanno ridotto la capacità fiscale nei Paesi donatori, mentre il cambiamento delle priorità nelle loro politiche interne li ha spinti a riassegnare risorse verso sicurezza e welfare domestico. Allo stesso tempo, l’alto debito pubblico, la “donor fatigue” dovuta alla proliferazione di crisi globali e una crescente revisione critica del ruolo degli aiuti – spesso subordinati agli interessi nazionali – hanno ulteriormente ridimensionato i fondi disponibili, con conseguenze dirette sui Paesi e le categorie di popolazione più vulnerabili.
Per quanto riguarda l’assistenza umanitaria, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) stima che i fondi ricevuti per il 2025 rappresentino soltanto il 23% dell’obiettivo prefissato (circa 2,4 miliardi di dollari ricevuti sui 10,6 miliardi necessari)[1]. Questo ha ridotto fortemente e ridurrà ulteriormente la capacità del settore umanitario di rispondere in maniera tempestiva ed adeguata alle emergenze. Ad oggi infatti, l’UNHCR stima che 11,6 milioni di rifugiati e sfollati siano a rischio di esclusione dal ricevere assistenza umanitaria – con gravi implicazioni a livello sociale, educativo e sanitario[2].
L’impatto negativo della riduzione dei finanziamenti non si è registrato solo nel settore umanitario ma anche in quello dello sviluppo. Nel 2025, l’UNICEF ha visto una diminuzione del 24% dei fondi destinati all’educazione rispetto al 2023. Questi fondi sono vitali per fornire alcuni servizi essenziali all’interno delle scuole, come i programmi di alimentazione scolastica. Attraverso il programma, milioni di studenti ricevono spesso quello che è l’unico pasto adeguato e bilanciato della loro giornata. La cancellazione di questo e altri servizi ha portato e porterà a un declino della qualità dell’educazione ricevuta per almeno 290 milioni di bambini a livello mondiale, con fino a sei milioni in più di bambini che potrebbero non frequentare la scuola entro il 2026[3]. Di questi, 1.9 milioni sarebbero in Africa occidentale e centrale[4]. Per quanto riguarda la nutrizione e la salute, le riduzioni del budget dedicato minacciano servizi primari per gravidanze, cure pediatriche, la salute riproduttiva e prevenzione, screening e cura di malattie come tubercolosi e HIV/AIDS ma anche della malnutrizione. Secondo le stime di UNAIDS, i prossimi anni vedranno una capacità fortemente limitata degli Stati dell’Africa subsahariana di fornire questi servizi – in particolare quelli legati alla prevenzione e al trattamento del HIV/AIDS[5]. Nell’area più colpita al mondo da questa malattia, questo rischierebbe di tramutarsi in un rallentamento significativo nel raggiungimento dei target prefissati per la riduzione delle nuove infezioni.
Se la tendenza non verrà invertita, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile rischiano di restare fuori portata, soprattutto in regioni già fragili come l’Africa subsahariana. Se prolungata infatti, la chiusura di strutture sanitarie e i tagli alla nutrizione infantile risulteranno in un aumento di malattie e malnutrizione, mentre la sospensione di programmi educativi e di protezione minerà ulteriormente l’accesso all’istruzione e la tutela dei più vulnerabili. Queste interruzioni faranno perdere capitale umano e renderanno Paesi già vulnerabili ancora più esposti a crisi future, con conseguenze ed effetti ancora più devastanti – con il rischio di compromettere gravemente i loro processi di sviluppo. La prestigiosa rivista medica The Lancet stima che i tagli apportati ai fondi per lo sviluppo porterebbero a una riduzione delle cure mediche e aiuti alimentari tale da provocare oltre 14 milioni di morti evitabili entro il 2030, 4,5 milioni dei quali bambini[6].
Per evitare questo scenario, serve un rinnovato impegno politico da parte dei donatori, capace di garantire risorse stabili e prevedibili nel tempo, e parallelamente è necessario rafforzare le capacità locali, affinché i paesi partner possano sostenere in autonomia i propri sistemi sanitari, educativi e produttivi. In questo contesto, Humana People to People continua a collaborare con le comunità attraverso i suoi progetti già radicati nelle realtà locali: rafforzando i sistemi sanitari di base con programmi di prevenzione e cura dell’HIV, della malaria e della tubercolosi; supportando la sicurezza alimentare con iniziative di agricoltura sostenibile e formazione dei piccoli agricoltori; promuovendo l’accesso all’istruzione e lo sviluppo di competenze per i giovani; e creando reti di resilienza comunitaria capaci di rispondere a crisi climatiche ed economiche. Lavorando fianco a fianco con le comunità, Humana costruisce soluzioni durature che riducono la dipendenza dagli aiuti esterni e rendono le comunità protagoniste del proprio sviluppo sostenibile nel corso del tempo.
Parallelamente, in un contesto in cui la dipendenza da fondi pubblici internazionali si dimostra sempre più fragile, anche le aziende possono svolgere un ruolo cruciale come donatori: non si tratta solo di compensare un vuoto economico, ma di cogliere l’occasione per ridefinire il rapporto tra profit e non profit, e soprattutto introdurre nuovi modelli più resilienti e orientati a un impatto sociale sostenibile, attraverso donazioni strategiche e collaborazioni strutturate. Le imprese possono offrire risorse finanziarie, ma anche competenze manageriali, infrastrutturali, tecnologiche, creando partnership con le ONG per innovare il fundraising e migliorare l’efficacia operativa. Possono dunque contribuire a un cambio di paradigma: da finanziamenti vincolati e di breve periodo verso progetti a lungo termine, basati su fiducia, trasparenza e investimenti che mantengano continuità anche nei momenti di crisi. Con queste premesse, la responsabilità sociale può diventare un motore strategico per l’innovazione del Terzo Settore, offrendo alle aziende un ruolo chiave nel ripensare il futuro della solidarietà.
[1] https://www.unhcr.org/news/briefing-notes/unhcr-funding-cuts-bite-some-11m-people-are-losing-aid
[2] Ibidem
[3] https://news.un.org/en/story/2025/09/1165764
[4] Ibidem
[5]https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2024/september/20240919_debt
[6] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(25)01186-9/fulltext